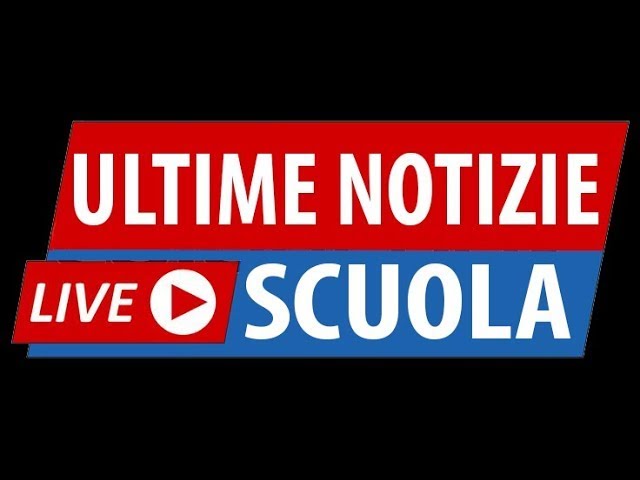Una constatazione: gli studenti italiani studiano l’inglese per almeno tredici anni (cinque nella scuola primaria, tre nella secondaria di primo grado, cinque nella secondaria di secondo grado).
Una domanda: quanti, al termine del percorso, sanno sostenere una conversazione quotidiana con un parlato scorrevole e senza costringere l’interlocutore a ripetere parole o intere frasi? Non sono in possesso di dati statistici sull’argomento e rispondo per esperienza diretta: pochissimi. E questi pochi di solito hanno affiancato allo studio a scuola altre esperienze formative: soggiorni all’estero, corsi vari ecc.
Mi è stato insegnato – e mi sforzo di comunicare questo insegnamento ai miei alunni – che quando si smarrisce la strada l’azione più saggia da intraprendere è tornare indietro fino al punto in cui ci si è persi e da lì cercare altre vie.
Ragioniamo un attimo insieme. Le abilità di una lingua sono fondamentalmente quattro: ascoltare, parlare, leggere e scrivere. L’ascolto migliora il parlato, la lettura migliora la scrittura.
Ecco, a mio modo di vedere, il primo, fondamentale errore: l’insegnamento dell’inglese nella scuola italiana è basato soprattutto sul libro di testo, vale a dire sulla lettura, sulla scrittura e sulla grammatica. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: alunni che comprendono (anche bene) e sanno produrre (discretamente) testi scritti di un certo livello, ma stentano nel parlare e non capiscono quando un inglese rivolge loro anche semplici frasi.
Alla luce di ciò, dobbiamo domandarci: è più importante, secondo noi, che i nostri studenti sappiano parlare la lingua o che sappiano scriverla? Dove vogliamo arrivare? Una scelta bisogna purtroppo farla, perché le ore di inglese non sono infinite. Se preferiamo la scrittura, allora il sistema attuale va abbastanza bene e allora si continui così; se invece ci rendiamo conto che è meglio assegnare la preferenza al parlato, occorre ripensare il tutto.
La mia proposta? Assegnare più importanza all’ascolto. Sul mio blog (www.francescoschipani.blogspot.it) ho reso disponibile a titolo gratuito una metodologia per autodidatti che tiene conto delle principali criticità dell’insegnamento linguistico e che sarebbe bello adattare in classe in una vera ricerca-azione. In estrema sintesi, questi gli assunti di base:
1) Listening: l’ascolto è la chiave del parlato scorrevole. Tanto ascolto. Quanti minuti di un’ora di inglese nella scuola italiana sono dedicati all’ascolto?
2) Comprehensible input: acquisisci una lingua solo quando comprendi i messaggi che ti vengono rivolti (si vedano le ricerche del linguista Stephen Krashen). Questo significa che proporre ascolti troppo difficili è solo una perdita di tempo.
3) Repetition: nella scuola italiana si affronta un argomento, si correggono gli esercizi, si propone un altro argomento e via dicendo. Così non funziona: la mente ha bisogno di digerire le informazioni. Occorre ripetere.
4) Silent period: i bimbi ascoltano circa un anno e mezzo prima di produrre i primi suoni. Allo stesso modo, a scuola, visto che si hanno a disposizione ben tredici anni di tempo, bisognerebbe dedicare almeno un paio d’anni al solo ascolto. Ascolto di materiale comprensibile, si intende.
La via è percorribile, soprattutto se si tiene conto che a differenza del passato abbiamo la miniera Internet e i moderni strumenti multimediali (Lim, iPad ecc.). Usiamoli. “Non ci rendiamo conto” – sostiene il poliglotta Steve Kaufmann – “che siamo nell’età dell’oro dell’apprendimento delle lingue”.
Un’ultima riflessione, riguardo al Clil. L’idea di aumentare i tempi di esposizione dei ragazzi alla lingua attraverso l’insegnamento di una disciplina è ottima; non adeguata, mi pare, la traduzione in pratica da parte della scuola italiana.
Non adeguata per almeno un motivo: nella stragrande maggioranza dei casi, gli studenti sono esposti a una lingua di seconda, terza, quarta mano (spesso, il docente parla in un inglese approssimativo appreso da un altro docente italiano, il quale ha imparato l’inglese da un altro ancora che ha soggiornato in Inghilterra per due mesi). Tutto questo non è serio: grammatica scorretta, pronuncia approssimativa ecc. Sento spesso, per i corridoi, i commenti divertiti degli alunni riguardo agli errori di pronuncia dei loro insegnanti: “Hai sentito come ha pronunciato isola? Àisland!” (island). Il pericolo è la perdita di credibilità.
Il Clil potrebbe essere molto efficace a condizione che sia realizzato interamente da insegnanti madrelingua e soprattutto per un periodo di tempo lungo.
L’altra mia perplessità riguardo al Clil è legata all’aspetto dei contenuti. L’ostacolo linguistico, è innegabile, conduce inevitabilmente a una riduzione dei contenuti della disciplina. È vero che – ormai è diventato uno slogan – non siamo più nella scuola dei contenuti ma in quella delle competenze, ma è altrettanto vero che nei concorsi pubblici, nei test di ammissione alle facoltà universitaria e in tanti altri ambiti viene richiesto ai candidati di rispondere a domande di contenuto: come si chiama la bimba morta di peste di cui parla Manzoni nei Promessi sposi? Qual è la capitale del Botswana? La formula per calcolare l’area del trapezio? Il ciclo di Krebs: A) produce GTP, NADH e CO2; B) utilizza glucosio; C) fa parte della glicolisi anaerobica; D) fa parte della glicolisi aerobica; E) consuma ATP e produce CO2.
La situazione attuale è così: la scuola italiana trascura o – a voler essere buoni – mette in secondo piano i contenuti. Poi li pretende. Con gli interessi, verrebbe da dire.
Allora, i contenuti sono importanti o no? Mettiamoci d’accordo, una volte per tutte. Con serietà. E per il bene delle future generazioni.
Francesco Schipani